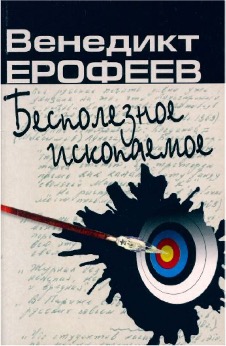[Scheda in allestimento]
Voci libere o condizionamenti del contesto?
Il portale che ospita questo contributo si intitola Voci libere in URSS. Tale denominazione struttura evidentemente la nostra comprensione del fenomeno della libertà di parola nel contesto sovietico come un fatto eccezionalmente raro o contrapposto alle circostanze, che resiste a questo insolito contesto o esiste nonostante esso (e contestualmente rappresenta forse l’unico relitto interessante di questa strana epoca). Ancor più ideologicamente etichettata, la “libertà di parola” è naturalmente concepita per resistere e infine sconfiggere le “condizioni totalitarie”, con un minimo di espansione economica e di influenza ideologica da parte dei sistemi concorrenti; ma come esigenza politico-epistemologica, la “libertà di parola” è percepita certamente meglio della sua assenza, della sua esistenza in contesti coercitivi o ancor più in presenza di rischi esistenziali e di minacce dirette alla vita e alla libertà. È proprio per avere un’opportunità esclusiva come la libertà di parola che, se il rovesciamento dei regimi totalitari tarda ad arrivare, i suoi paladini migrano nei “paesi democratici”, dove la loro voce può finalmente trovare piena libertà e la parola può fluire libera senza incontrare ostacoli. Senza ricevere però, va detto, neppure un grado di attenzione minimamente paragonabile: come notano con disappunto gli scrittori émigrés nelle loro memorie, “Là [nel contesto sovietico] non ci pubblicavano, ma quantomeno ci leggeva la polizia segreta. Qui veniamo pubblicati, ma non ci legge nessuno”. Il mutamento di ambiente porta l’autore (anti)sovietico a riconoscere un fattore istituzionale della “modalità sovietica” di produrre letteratura, come l’attenzione costitutiva della censura (‘non pubblicati, ma letti’), e dopo l’emigrazione, con l’arrivo in un ambiente presumibilmente libero da ogni condizionamento, l’inaspettata scomparsa di simili “condizioni di riuscita” dell’espressione letteraria (‘pubblicati, ma non letti’)[1].
Vorremmo ora esaminare più da vicino questo strano effetto per cui la parola sembra perdere la propria scommessa esistenziale proprio quando diviene libera e si viene a trovare in un mondo altrettanto libero da ogni condizionamento – eccezion fatta per la coercizione economica, che in qualche misura determina il grado di attenzione dato a ogni discorso. Ma oltre che rilevare questo effetto (definibile come effetto “Dovlatov-Vojnovič”) nella sociologia storica dell’epoca sovietica, potrebbe essere interessante indagare più a fondo e rintracciare qualcosa di simile anche nella storia della letteratura dell’epoca prerivoluzionaria. Nel suo articolo Sullo scrittore e la produzione, Šklovskij osservava che “Dostoevskij non mostrava rispetto per i romanzi che scriveva e voleva scriverne di altri; aveva l’impressione che i suoi romanzi fossero romanzi d’appendice; nelle sue lettere scriveva: ‘Se mi pagassero quanto Turgenev scriverei bene quanto lui’. Ma non fu pagato altrettanto eppure scrisse meglio. La grande letteratura non è quella che viene pubblicata sulle grandi riviste, bensì quella che fa un uso corretto della propria epoca”. Ne consegue che il discorso in questione non è interamente riducibile alla presunta, distorta topologia del processo letterario sovietico, poiché una qualche forma di censura è sempre esistita: utilizzare o persino sfruttare le pressioni della propria epoca, prendere consapevolezza e tenere conto dei condizionamenti del proprio ambiente può dunque rivelarsi non solo la sorte obbligata di chi per propria sfortuna si trova a vivere in un “contesto” totalitario, ma anche un obbligo più generalmente connesso a ogni invenzione verbale.
La capacità costitutiva del soggetto di comunicare è sempre mediata da certi condizionamenti politici e dalla materialità della comunicazione. Da sempre nella storia, cittadini informati non sono solo il merito di politiche illuminate o addirittura l’obiettivo di indottrinamenti ideologici, ma anche il risultato di negoziazioni efficaci tra cultura e tecnologia (R. Debré). La diffusione di quella che viene comunemente chiamata “libertà di parola” è accompagnata sia da specifiche modalità di appropriazione dell’informazione (R. Chartier), sia dalla collusione del messaggio con il mezzo (M. McLuhan), mentre il diritto all’espressione e la capacità di parlare (G. Spivak) sono legati all’apprendimento di nuove tecniche mediatiche di comunicazione e vengono garantiti dalla velocità di invio dei messaggi (F. Kittler). Pertanto, l’istituto della “libertà di parola” non può essere affatto ricondotto a un’operazione trascendentale speciale; al contrario il più delle volte il modo di parlare si scopre essere non tanto un diritto civile, quanto un obbligo[2].
I media e più ampiamente le tecnologie culturali precedono ogni sorta di soggettività, la sfera pubblica e le altre virtù liberali. La storia dei media esclude quel tipo di ottica consumistica in cui tutto sembrerebbe esistere solo per la comunicazione privata dei cittadini finché lo Stato non vi interviene, e la tecnologia apparirebbe solo nel momento in cui “l’amichevole interfaccia” si affaccia nel mercato[3]. Il “contesto sovietico” è interessante anche solo per il fatto che esso rimuove ogni illusione di spontaneità delle “voci libere”, dato che i sempre esistiti condizionamenti tecnologico-ideologici rivelano più precisamente come il contesto e le tecniche di comunicazione collettiva determinino tutti i contenuti trasmessi (dalle “voci libere”). Nessuno сhe conosca bene il “contesto sovietico” ha dubbi sul fatto che gli apparati ideologici dello Stato avessero accumulato ritardi (rispetto al desiderio di “voce libera”) o non fossero sufficientemente equipaggiati sul piano tecnologico, in un paese in cui il potere sovietico era andato di pari passo con l’elettrificazione sin dalla sua nascita. In tal senso, la poesia, e più in generale la letteratura, da un lato si batte sempre per il verso libero e per le parole in libertà (non senza che questo abbia implicazioni politiche), e dall’altro sperimenta costantemente limitazioni formali e combinatorie autoimposte, nella piena consapevolezza che ogni volta è necessario ottenere personalmente questa libertà di parola attraverso una fitta negoziazione con i condizionamenti politici e tecnologici[4]. Ecco perché la poesia d’epoca sovietica può rivelarsi particolarmente utile a comprendere le condizioni essenziali della “libertà di parola” nell’era della geoposizione linguistica.

Murale con il poema grafico di D. Prigov a Beljaevo, Mosca.
La geoposizione linguistica
A questo punto vorrei passare a precisare la mia personale geoposizione linguistica. Quest’ultima non è legata soltanto a un parametro geografico, quindi al luogo in cui mi trovo ora, ad esempio Pisa, o a quello da cui vengo, sia nel senso specifico di questa circostanza, o dell’anno trascorso, o proprio originariamente: ad essere implicato è anche il modo in cui le zone di interazione sono immaginate e correlate le une con le altre, risultando così simbolicamente investite dai vari lati, il che sembra acquisire sempre più importanza al giorno d’oggi.
Il primo ad aver mostrato una certa sensibilità per la categoria della geoposizione linguistica e ad aver focalizzato il mutamento di regole del comportamento verbale nei circuiti del samizdat e del tamizdat è stato probabilmente Dmitrij Prigov, una tra le figure di spicco della letteratura non ufficiale. Mentre portava le sue poesie e le sue opere d’arte in giro per il mondo, quest’ultimo si presentava continuamente come un “Accademico di Beljaevo”, denominazione che fa riferimento alla stazione Beljaevo della metropolitana di Mosca, una delle più lontane dal centro. Nel fare questo, Prigov intendeva evidentemente dichiarare la sua posizione di parlante dalla periferia (Beljaevo) che un giorno avrebbe dovuto ottenere il potere centrale (Accademico). Purtroppo, tutto questo non è ancora accaduto e adesso persino il murale con il suo testo a Beljaevo è stato distrutto dal potere centrale o municipale addirittura.
La relazione centro-periferia era alla base non solo delle posizioni linguistiche di quei poeti che tentavano di poeticizzare la loro collocazione: un simile modello di autocostruzione regolava anche le partenze tattiche dall’Unione Sovietica verso l’emigrazione. All’epoca, la cosa più importante era quest’azione, era una valigia che potesse funzionare come un’arca o un santuario per i manoscritti, una capsula materiale e simbolica con cui lasciare definitivamente la città. Che si trattasse di manoscritti propri (il caso di Brodskij) o di testi di un qualche circolo (il caso di Kuz’minskij), la valigia dello scrittore veniva portata via da Leningrado una volta per sempre. Avendo abbandonato fisicamente la città, questi scrittori in qualche modo ne hanno messo simbolicamente l’essenza in valigia e con essa hanno viaggiato per tutta la vita. A seconda del suo contenuto, la valigia forniva la base per una successiva traiettoria nelle università americane nel ruolo del poeta laureato o quantomeno del poeta che tenta di vendere le sue antologie. Gli scrittori emigrati potevano negoziare o addirittura scambiare il loro capitale con l’intonazione cronica di un espatriato o con quella di messaggero di un continente sommerso, ma da quel momento non avevano più la possibilità di tornare in patria per le vacanze. In sintesi, la posizione linguistica dell’emigrato rimaneva tale per tutta la vita.

I. Brodskij sulla sua valigia a Pulkovo, Leningrado, 1972.
La nostra generazione ha già rilevato importanti cambiamenti nel comportamento di scrittura e di pubblicazione connessi a trasferimenti su ampie distanze geografiche. La tradizione leningradese dei manoscritti salvati in una valigia – durante la guerra, l’assedio o l’emigrazione – ma anche l’antologia intesa come genere derivato da questo oggetto fisico, stanno subendo notevoli modifiche. La figura del poeta che lascia la città per un esilio strategico con una valigia piena di manoscritti è stata sostituita da quella di un poeta-editore che traghetta semplicemente un nuovo numero da oltreoceano, o da quella di un poeta-performer che mostra i suoi nuovi video all’ennesima conferenza internazionale sulla poesia (post)sovietica.
In ogni caso, dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica e l’affermazione del Mondo Libero, non è sembrato troppo importante riflettere, chiarire e persino dichiarare in modo rigoroso la propria posizione geografica in relazione al linguaggio. Tuttavia, gli avvenimenti degli ultimi anni, con una marcata accelerazione nell’ultimo, hanno prodotto un radicale cambiamento nella nostra percezione dei parametri di comunicazione. In primo luogo, chiaramente, va menzionato il Covid, che ha tramutato la rivista cartacea da me diretta in un laboratorio online, e immagino che molte persone abbiano notato un cambiamento analogo nelle loro pratiche di comunicazione, quando è ormai diventato d’obbligo specificare non più dove si svolge il dato seminario, ma il fuso orario di riferimento e il link per accedervi[5].
Infine, è arrivato il 24 febbraio. Come è facile intuire, le prime reazioni intellettuali a questo evento hanno replicato in misura significativa il repertorio di gesti e discorsi propri della biopolitica della Guerra Fredda. La nuova legge sulla censura stabilisce che nessuna forma di critica è legale e dunque possibile senza rischi; di conseguenza, se non si è d’accordo con la linea politica generale e lo si vuole esprimere pubblicamente, si deve (essere pronti ad) andare in prigione. Ad ogni modo, la maggioranza delle persone ha optato per lasciare la Russia: rimanere ‘all’interno’ del paese ha iniziato a significare che si abbraccia pienamente o che quantomeno si accetta il corso politico principale (in modo doloroso o impotente)[6].
Ma, naturalmente, la situazione attuale non si limita a riproporre la spaccatura culturale e ideologica tra coloro che partono per una vera e propria emigrazione e coloro che invece si calano nella clandestinità o nella cosiddetta “emigrazione interna”: le circostanze attuali differiscono strutturalmente perlomeno perché il controllo biopolitico opera in modo più spersonalizzato e algoritmico. Un tipico esempio di censura più mirata sul singolo è quello per cui, stando alla leggenda, Stalin poteva chiedere ai poeti di valutare il talento dei loro colleghi (Pasternak su Mandel’štam). Anche i casi di “almeno ci legge la polizia segreta” sono ormai impossibili: oggi non esiste un’infrastruttura comunicativa equivalente per cui qualcuno può essere imprigionato per la barzelletta raccontata in cucina come ai tempi di Stalin, ma si viene imprigionati per aver ripostato qualcosa, venendo localizzati in modo automatico. La formula per determinare il grado di pericolosità di un’affermazione oggi include anche il coefficiente numerico dei follower – indicatore puramente quantitativo e dunque maneggiabile da un algoritmo, senza che si tenga conto dell’analisi semantica. Questo accade perché il discorso circola attraverso altri canali e a una velocità differente. Il vecchio orizzonte ideologico ci impedisce di cogliere le regole di circolazione degli affetti nella comunicazione contemporanea. I social media continuano a produrre dichiarazioni “da lì” (lo stato totalitario) e dichiarazioni “da qui” (il mondo libero): il problema è che queste dichiarazioni oggigiorno si trovano in uno strano regime di vicinato elettronico[7]. Oggi come allora questi due tipi di esternazioni differiscono fortemente non solo per il contesto di provenienza, ma anche per il loro valore esistenziale fondamentalmente diverso. Essendo estremamente limitati nella scelta delle espressioni, coloro che parlano pubblicamente (anche in forma poetica) “da lì” e ne sperimentano i rischi sono incomparabili a coloro che parlano “da qui”[8]. La loro prossimità nelle bacheche virtuali, che fino a poco tempo fa poteva essere anche prossimità di posizione geografica, è ora deludente, considerata la netta divergenza della situazione esistenziale in cui si trovano a vivere gli uni e gli altri. È proprio questa forte limitazione delle capacità del discorso, ora dipendente più che mai dalla propria

Copertina dell’ultimo numero russo di “Translit” – 25 : Bol’še net slov [non ci sono più parole].
Nel caso della poesia, ad esempio, si può osservare come ormai sia diventato di gran lunga più importante considerare da dove viene scritto il testo (dalla trincea, dal proprio divano o da un resort), che non quel che esso dice (i pensieri e i contenuti possono anche essere presi in prestito da altri). Questo livello di “contenuto” era già stato a suo tempo messo in discussione o comunque destabilizzato dai formalisti con la loro domanda sul come. Ora neanche il come sembra essere tanto importante quanto il da dove. È sufficiente immaginare una poesia che presenti tratti radicali a livello di forma, ma che sia stata scritta da un luogo sicuro per la propria incolumità fisica o addirittura abbiente sul piano istituzionale, e poi immaginare la stessa poesia scritta durante la guerra: l’apprezzamento del suo radicalismo formale rimarrebbe lo stesso?
Inoltre, è necessario prendere in considerazione i parametri mediatico-tecnologici di circolazione e ricezione delle dichiarazioni. Se tutto, dalle opinioni e le riflessioni sino alla poesia, può ormai essere pubblicato istantaneamente sui social network, esso diviene però tracciabile, il che vuol dire poter identificare il luogo di enunciazione fuori dallo spazio virtuale. Pertanto, è possibile proporre una categoria come la “geoposizione linguistica”, che oggi determina, se non tutto, ma quantomeno molto del valore di ciò che viene detto (e di come). Tale categoria sembra in qualche modo predeterminare ciò che può essere detto, dotandolo di maggiore o minore significato. Naturalmente, esistono quadri di riferimento morali in concorrenza fra loro, la cui polarizzazione non fa che aumentare l’attenzione verso questo fenomeno. Comprendere la funzione discorsiva e simbolica, politica e poetica della geoposizione linguistica è una necessità epistemica.
Come la maggior parte degli argomenti sullo stato di emergenza, l’idea di valutare una dichiarazione in rapporto alla geoposizione del parlante, ora applicabile ovunque, esisteva anche prima, seppur in forme differenti. La cancel-culture prebellica (o anche quella di inizio guerra, con dei contorni leggermente diversi) ha delle analogie strutturali. Il valore di tutto ciò che veniva pronunciato, ad esempio, da un uomo bianco cisgender, per circostanze pragmatiche simili, veniva automaticamente demolito da “alcune comunità interpretative” e a sua volta questo dava rilievo ad altri parlanti. Nel caso poi in cui quest’uomo fosse anche morto e fosse una figura con una eredità e un valore storico riconosciuti, magari persino commemorati da un monumento, allora anche quest’ultimo doveva essere demolito. Al di là delle giuste lotte etiche ed epistemiche per revisionare la nostra economia dell’attenzione, i meccanismi soggiacenti devono diventare oggetto di riflessione, in quanto sono veicolo ed espressione sintomatica dell’ontologizzazione del chi e a livello strutturale preparano persino il significato del da dove.
Note:
[1]Per maggiori dettagli sulla situazione della rete di attori della letteratura tardo-sovietica cf. il saggio a mia firma «Писать дефицитом»: Дмитрий Пригов и природа «второй культуры».
[2] Come uno studioso contemporaneo suggerisce di cambiare la formula di Spivak “gli oppressi devono (imparare a) parlare” proprio a partire da una specifica struttura discorsiva, nel caso sovietico delle origini questa era il giornale (e più tardi la radio). Kalinin I. The Oppressed Must Speak (Mass Appeal to Literature and the Formation of the Soviet Subject, 1920s – Early 1930s) // There, Inside. Practices of Internal Colonization in Russian Cultural History M.: Novoe Literaturnoe Obozrenie, 2012. С. 587-664.
[3] In questo mi rifaccio metodologicamente alla media-archeologia di Bernard Siegert, che ha studiato il cursus publicus, il servizio postale dell’Impero Romano, che fu creato dall’Imperatore e inizialmente escludeva l’uso privato (Siegert B. The Fall of the Roman Empire // Materialities of Communication, 1994. P. 303-318).
[4] Questa correlazione fra materiale e ideologia è già stata affrontata nel mio contributo Arseniev P. The power of the word and its socio-technical amplifications (relazione della conferenza sulla poesia) //#23 [Транслит]: Материальные культуры авангарда.
[5] Alcune intuizioni su queste nuove forme di comunicazione e di educazione umanitaria sono state discusse sulla rivista “Translit”, cf. #24 [Транслит]: Карантинное (ново)образование.
[6] Già nel 2014, l’annessione della Crimea e la guerra del Donbass avevano creato una spaccatura nei gruppi di opposizione. Invece di un’opposizione coesa, sono emersi due fronti: quelli che erano a favore della “nostra Crimea” e quelli che erano contrari. Ma all’epoca era ancora possibile criticare le posizioni nazionaliste e imperialiste di coloro che erano per la “nostra Crimea” e coesistere fisicamente con loro. Nel 2022 questa spaccatura ha acquisito un carattere esistenziale. Per un quadro più esaustivo cf. l’intervista rilasciata a Natal’ja Grinina: Speechlessness: Conversation with Pavel Arsenev about Russian anti-war poetry.
[7] Come se Brodskij e Evtušenko avessero entrambi bisogno di esprimere la propria posizione in relazione al kolkhoz, il che portò a risultati piuttosto singolari, come è noto.
[8] Anche l’assenza di tali vincoli, che significa parlare non da “lì” (in Russia), è vissuta con maggiore o minore delusione, ora come allora.
[9] Cf. la copertina e la descrizione dell’ultimo numero di “Translit”, http://www.trans-lit.info/vypuski/25-net-slov.
Pavel Arsen’ev
[31 maggio 2024]
Traduzione di Cecilia Martino
Il testo è tratto dalla lezione che l’autore ha tenuto il 15 marzo 2023 nell’ambito del corso di Dottorato in Discipline Linguistiche e Letterature Straniere dell’Università di Pisa.